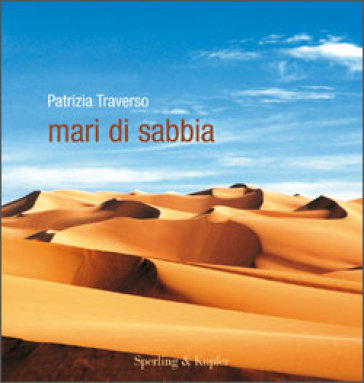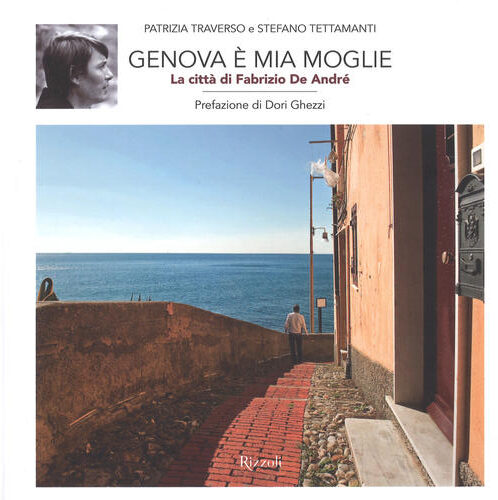Il termine “fotografia” deriva dal greco φῶς, φωτός, luce e -grafia γραϕία, scrittura, ovvero “scrittura di/con la luce”; Fotografare ( con la F maiuscola per distinguerla dall’uso funzionale, troppo spesso anche disfunzionale, che sperimentiamo quotidianamente ) è una declinazione del linguaggio umano, dove le immagini, attraverso evocazioni, testimonianze, illusioni, allusioni, riescono a comunicare al di là della rappresentazione, mettendo in relazione il coinvolgimento emotivo, culturale, storico di tutti i soggetti partecipanti: fotografo, soggetto/oggetto fotografato, osservatore.
La Fotografia è uno dei mezzi espressivi più usati del nostro tempo, per questo riteniamo che in uno spazio dove si parla di scrittura sia importante parlare anche di scrittura-con-la-luce, indagando le sue potenzialità comunicative e contribuendo alla divulgazione del lavoro autoriale che troppo spesso rimane emarginato.
La nostra prima ospite è la fotografa Patrizia Traverso, che con il suo stile, fatto di immagini e non solo, ci proietta in una nuova dimensione del vedere e del sentire.
Foto e intervista di Gianluca Russo
Patrizia, l’intensità ed il fascino di questo luogo sono evidenti e non ti nascondo che spero di avere l’occasione di tornare a fotografare questi spazi, ma perché hai scelto questo posto per la nostra intervista e in che modo ti rappresenta o ti appartiene?
Il manicomio di Quarto è stato per un secolo il luogo della grande rimozione, il buco nero in cui una città teneva nascoste, insieme ai suoi scemi, le sue vergogne, le sue paure e le sue colpe. Dopo la sua chiusura, in questi immensi padiglioni dalla sinistra bellezza, nei corridoi infiniti, nei cortili silenziosi, continua ad aleggiare la memoria di ferite incancellabili. A Quarto, dal 1978 al 1993, ha operato come direttore Antonio Slavich, una delle figure più eminenti della psichiatria italiana, fra i principali collaboratori di Franco Basaglia. Se un orgoglio può avere la mia generazione è quello di avere accompagnato appassionatamente l’intero iter di elaborazione, approvazione e applicazione della legge Basaglia, una delle leggi fondanti della nostra democrazia. Sin dalla prima volta in cui sono capitata in questo luogo ne ho subito il fascino e ho provato senso di appartenenza. Talvolta accompagno in visita amici genovesi o “foresti” per condividere con loro la gioia di aver visto restituire alla città uno dei suoi spazi più ricchi di storia e bellezza, senza però aver rimosso le sofferenze del passato.
In merito al progetto “Lo Spazio 21”, sei coinvolta attivamente, vuoi raccontarci qualcosa di più ?
Il progetto Spazio 21, che si colloca al centro del reticolo ortogonale che forma il complesso ottocentesco dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto e occupa il luogo dove erano attive le cucine, si prefigge di organizzare attività di memoria, ricerca ed espressione per una cultura condivisa della salute, coinvolgendo la comunità locale e tutta la città attraverso mostre, incontri culturali, presentazione di libri, rappresentazioni cinematografiche e teatrali. Il progetto si basa sul rispetto della persona, con particolare attenzione alla sua salute in sinergia con la Casa della Salute del Levante da poco inaugurata e sul concetto di comunità “… in una comunità aiutarci reciprocamente è un nostro puro e semplice dovere, così come è un nostro puro e semplice diritto aspettarci che l’aiuto richiesto non mancherà” (Zygmunt Bauman). In futuro nello spazio 21 dovrebbe essere allestito il MAdFI, Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli, fondato nel 1992 dall’artista Claudio Costa, che ha raccolto, senza alcuna separazione, espressioni artistiche sia di persone con problemi psicopatologici, sia di artisti professionisti che hanno aderito all’iniziativa. Il mio coinvolgimento consiste nel partecipare alle riunioni del Coordinamento, un organo composto da volontari, che, oltre a proporre le iniziative socio-culturali, da anni si batte perché venga rispettato quanto stabilito nell’Accordo di Programma del 2013 che ha tracciato le diverse aree dell’enorme complesso suddivise tra Regione Liguria, Asl 3 Genovese, A.R.T.E. Liguria e Comune di Genova e di conseguenza venga definitivamente stabilita l’assegnazione degli spazi destinati alle nostre attività.
Sei stata arredatrice, libraia, traduttrice, hai lavorato nel settore dell’editoria dei libri d’arte; insomma una personalità assolutamente poliedrica, quando e come nasce invece la Patrizia Fotografa?
Sono convinta che in realtà la Patrizia Fotografa ci sia sempre stata e abbia convissuto, più o meno serenamente, con tutte le altre Patrizie. Qualche giorno fa da un trasloco sono emerse le attrezzature fotografiche (una camera oscura completa di ingranditore vintage) che usavo a vent’anni, quindi prima di tutte le altre metamorfosi. Anzi, oggi mi piace pensare che la fotografia sia stata il fil rouge che ha tenuto insieme tutte le altre me stesse. Anche se forse una consapevolezza maggiore di che cosa significhi fotografare l’ho avuto frequentando uno dei primi corsi di una mia illustre omonima, la grande Giuliana Traverso.
Fotografia e poesia, fotografia e parole, un matrimonio possibile, ne sono un esempio il tuo libro “Genova ch’è tutto dire – immagini per la ‘Litania’ di Giorgio Caproni”, così come “Genova è mia moglie”, dove la tua fotografia incontra i versi di De André, ma anche gli altri tuoi volumi, dove le tue foto vengono accompagnate da versi o pensieri di autori e di poeti.
Una scelta stilistica precisa insomma, mirata a creare, dalla fusione di due linguaggi, una terza dimensione espressiva. M’incuriosisce capire come evolve il tuo processo creativo, ovvero se cerchi l’immagine partendo dalle parole, oppure se l’abbinamento è un qualcosa che avviene successivamente.
Mi fa piacere che tu abbia colto questa cifra del mio lavoro, che è quella per me più significativa. L’idea è che con la fotografia non si immobilizza un’immagine nel tempo e nello spazio ma la si mette in comunicazione con altre immagini e con altre forme espressive – le parole della poesia innanzitutto, ma anche della musica, delle opere d’arte, dell’architettura, anche con la natura – perché dialoghino fra loro e ci restituiscano qualcosa di più della loro semplice somma. Cosa viene prima mi chiedi? Dipende. Quando ho lavorato sulla Genova di De André le parole di Fabrizio sono servite da apripista per fotografare una Genova che lui non ha potuto vedere e che prendeva forma dal mio sguardo. Con Caproni il processo è stato inverso e l’immagine di un poggiolo con un vaso di gerani sul mare di Boccadasse mi ha fatto immediatamente risuonare nelle orecchie un distico della “Litania”: Genova vecchia e ragazza/pazzia, vaso, terrazza.
Poi le parole di Luigi Surdich, il massimo conoscitore dell’opera di Caproni, hanno dato sostanza letteraria e profondità culturale, alle mie intuizioni visive. Quando Luigi ha accettato con entusiasmo di collaborare al mio lavoro ho avuto una gratificazione impagabile.
L’editing delle foto, ovvero la scelta delle foto, il taglio, le regolazioni di luci e i colori, è un lavoro complicato ed importante, quanto il momento dello scatto, almeno per quanto riguarda la resa finale dell’immagine. Come ti comporti a riguardo? Ti consigli con qualcuno o procedi in autonomia?
Se sto lavorando su un’immagine per la pubblicazione in un libro mi piace seguire in prima persona la delicata fase di impaginazione che sempre richiede un’attenta valutazione che dipende dalla dimensione del supporto cartaceo e dall’equilibrio che si intende dare tra immagine e testo. Uso la post-produzione il minimo indispensabile, anche se ne riconosco la valenza. Ammetto di non essermi mai applicata per conoscere a fondo le sue potenzialità, è un aspetto tecnico che mi annoia. In genere comunque il rapporto con i tecnici editoriali (e ce ne sono di straordinariamente capaci, sensibili, attenti e rispettosi) è fondamentale ed è per me un vero sollievo. Del resto la solitudine del lavoro artistico non fa per me, ho bisogno spesso del confronto, anche in corso d’opera, con gli altri, tecnici o no. Dei loro commenti, delle loro reazioni.
“Per questo lavoro sulla lettura ho voluto vincere le mie resistenze nell’affrontare il ritratto, un genere che in passato ho trascurato perché mi crea disagio la prepotente invadenza che l’obiettivo finisce inevitabilmente per esercitare nei confronti del soggetto fotografato e non apprezzo che il risultato possa essere troppo condizionato dalla personalità dell’autore e dalla percezione che il soggetto ha di sé”.
Questo è un passaggio della nota al tuo libro “Preferisco Leggere”. Premesso questo, possiamo constatare che con il ritratto ti sei misurata e il risultato è stato notevole. Qual è stata la tua chiave di interpretazione per trovarti a tuo agio nel fotografare le persone? Come è nata l’idea di indagare il variegato mondo dei lettori e cosa ti ha lasciato quest’esperienza? Ti ritroveremo a misurarti con il fotografare le persone?
A ripensarci non sono convinta che in “Preferisco leggere” ci siano poi così tanti ritratti, quasi tutte le persone che leggono sono state fotografate a loro insaputa o colte di sorpresa, spesso sono scatti rubati. Insomma non mi pare ci siano ritratti nel senso tradizionale del termine: persone in posa, set studiato, guardi l’uccellino, clic… E comunque anche così, rubando le foto come una ladra, ho avuto un bel po’ di imbarazzi, continuo a pensare che ci voglia un grande concetto di sé per pretendere di cogliere l’essenza di un essere umano attraverso uno scatto fotografico. Ora che ci penso anche di fronte ai gatti ho provato un po’ di imbarazzo, anche se almeno loro erano naturali nel mettersi in posa. A proposito del mondo dei lettori, mondo del quale faccio parte, devo ammettere di aver avuto come modello mio marito: averlo visto leggere per ore nei posti più strani e nelle posizioni più impensabili mi ha aiutato non poco. Non credo farò mai un lavoro fotografico sui ritratti, il mio sguardo fotografico si focalizza sui colori, sulla ricerca di armonia nelle forme inanimate, si concentra sull’equilibrio delle linee e dei volumi nell’ambiente e nello spazio. Mi interessano soprattutto la natura e l’architettura, il loro essere condizionate e modificate dalla luce, l’elemento essenziale della fotografia, e dall’aria, l’elemento essenziale della vita.
John Berger nel suo libro “Capire una fotografia”, scrive: “Il vero contenuto di una fotografia è invisibile, poiché deriva da un gioco, non con la forma, ma con il tempo.” Qual è l’invisibile che cerchi di catturare (trattenere) nelle tue fotografie? Qual è il tuo “tempo” fotografico?
Il mio sogno è fotografare la musica, non i musicisti mentre suonano, ma la loro musica. Un altro progetto è fotografare il silenzio. Chissà. Progetti ambiziosi. Anche le ombre mi affascinano. E la risacca del mare. Ho provato col vento. Ci proverò ancora.
Nel tuo percorso, c’è un fotografo autoriale, noto, o meno noto, che ti ha particolarmente influenzata? Come valuti la fotografia del nostro tempo?
Scegliere un solo fotografo tra i tanti grandi fotografi, uomini e donne, che mi hanno influenzato è una piccola tortura. Per renderla un po’ meno dolorosa lascia che ne indichi almeno due, lontani fra loro per epoca e formazione, l’americano Ansel Adams con i suoi panorami in bianco e nero e l’italianissimo Franco Fontana con i suoi accesi cromatismi. Mi riconosco nella ricerca degli spazi infiniti di Adams e nel gusto delle geometrie colorate di Fontana. Sulla fotografia del nostro tempo. Be’, è impossibile prescindere dalla constatazione che la fotografia contemporanea sia sempre più un fenomeno di massa, complice l’uso dei cellulari e la sua diffusione sui social media. La proliferazione esponenziale di immagini ha portato a un inquinamento del contenuto fotografico, non si diventa scrittori solo perché si possiede un foglio e una penna e allo stesso modo si dovrebbe essere più consapevoli del ruolo espressivo e comunicativo della fotografia, del suo potere sociale. Si dovrebbe tenere a mente Cartier-Bresson quando dice: “è un illusione che le foto si facciano con la macchina… si fanno con gli occhi, con il cuore, con la testa”. Occhi, cuore e testa che vedo ben poco presenti nella pandemia di immagini che oggi ci travolge.
Fra le domande di rito ai nostri intervistati, per l’iniziativa #iltuoritrattoinunlibro, chiedo di portare il proprio libro del cuore, tu ne hai portati due. Ci motivi la tua scelta? Quali momenti hanno segnato della tua vita? E se proprio dovessi sceglierne uno?
Come si fa a scegliere un solo libro tra quelli di una vita? Visto però che mi hai richiesto di sottopormi a questo gioco crudele, ho pensato a due libri che hanno segnato due momenti significativi del mio passato, per questo non mi va di sceglierne uno solo, sono due aspetti diversi del mio vissuto e sceglierne uno significherebbe rinnegare l’altro. Il primo, in ordine di tempo, è il catalogo della bellissima mostra di Henri Moore al Forte Belvedere di Firenze nell’estate 1972: ha segnato l’inizio della mia passione per l’arte contemporanea, passione che ho continuato a coltivare negli anni e che non mi ha mai abbandonato. Ho avuto l’opportunità di occuparmene a livello professionale fra il 1995 e il 2004 alla Libreria Ducale, un bookshop all’interno di Palazzo Ducale, che ora non esiste più, dedicato all’editoria d’arte e al merchandising museale. L’altro libro che ho portato è “Tsotsi”, unico romanzo di Athol Fugard, grande drammaturgo sudafricano. È stato il mio primo lavoro di traduzione, nel 1991, un lavoro faticoso, anzi estenuante, ma straordinariamente gratificante. Non mi era mai capitato di entrare così a fondo in un testo, di apprezzarne anche i minimi risvolti, linguistici e letterari, di dover riflettere per ore sulla scelta di un aggettivo o l’impostazione di una frase. E poi da quel lavoro è nato uno dei più bei viaggi che abbia mai fatto, in Sudafrica, nei luoghi dove Tsotsi è ambientato. Potevo dimenticarlo?
In queste due foto ti vediamo invece accompagnata con due oggetti differenti, una molla di metallo e un modellino di legno. Hai accettato di buon grado l’idea di portare un qualcosa a te caro, anche perché mi hai confessato di esserne un’appassionata, quindi, a maggior ragione, perché hai scelto proprio questi due? Quale significato speciale hanno per te? La tua passione per gli oggetti la ritroviamo anche nelle “fotocose”, fotografie arricchite con elementi fisici, tangibili, esterni all’immagine, ce ne vuoi parlare?
L’esperienza professionale nel campo dell’arredamento mi ha condizionato, quindi, in occasione della pubblicazione del libro “Mari di sabbia” (frutto di un viaggio nel Sahara libico) e all’opportunità di esporre le foto del libro in una mostra a Palazzo Rosso, ho progettato le “fotocose” stampe fotografiche sulle quali ho inserito materiali vari e oggetti evocativi del deserto. Per quanto riguarda la scelta degli oggetti che mi rappresentano, devo dire che neppure questa è stata facile perché da sempre accumulo oggetti più o meno insensati, raccolti nei viaggi o semplicemente notati per la loro forma o il loro colore. Ho sempre tenuto una molla sulla scrivania. Non ha nessuna utilità pratica, ma trovo sia un oggetto divertente e interessante, mi piace giocare con la sua flessibilità (che è anche un po’ mia? Intendo mentale, non fisica). L’omino snodabile di legno per artisti è una presenza/assenza che stimola la mia creatività fotografica, anche questo è un oggetto flessibile capace di assumere posizioni improbabili di assoluta efficacia fotografica giocando con la luce e le ombre che produce.
Rimanendo in tema di tridimensionalità fotografica, non possiamo non citare un’altra tua invenzione, le “fotopagine”, ovvero immagini assemblate come un libro aperto. Non è stato pero facile realizzarle … ci racconti qualcosa di più?
Volentieri. Quando ho pubblicato con Tea il mio “Preferisco leggere”, un fotoracconto dedicato alla straordinaria varietà e bellezza che c’è non solo nella lettura ma nel semplice gesto di leggere, ho voluto fissare i momenti più intimi di quel gesto, il rapporto fra il lettore e il suo testo, un rapporto basato sulla scelta reciproca, sul rispetto, sulla complicità, sull’intimità, sull’allegria dell’anima, e li ho intrecciati con le parole di tanti artisti che hanno riflettuto sull’atto di leggere. Le “fotopagine” nascono dall’idea di presentare le stampe fotografiche relative a questo libro in forma tridimensionale, come pagine di un libro aperto. Ho progettato e fatto realizzare dei particolari supporti di acciaio magnetico sui quali potessero scorrere gli stralci dei pensieri letterari citati nel libro. In questo modo ho cercato di rendere “fisicamente” possibile l’elemento che considero imprescindibile in ogni mio racconto fotografico, l’incontro delle immagini con l’universo della scrittura.
Franco Fontana, in una recente diretta con Oliviero Toscani, ha dichiarato che non ha mai avuto modo di vedere il vento fotografato adeguatamente e che sarebbe disposto a premiare, con una sua foto autografata, colui o colei che ci fosse riuscito. Questo la dice lunga sulle difficoltà nel misurarsi con un soggetto così mutevole e inafferrabile, ma evidentemente Fontana non ha avuto occasione di sfogliare il tuo libro, “Buon vento”, dove invece tu magistralmente hai affrontato e superato la sfida. Perché hai scelto di fotografare il vento e quale è stata la tua strategia interpretativa per riuscire a rendere così bene le sue complesse caratteristiche?
Per chi, come me, è nato in una città di mare, il vento è un elemento non solo familiare, ma costitutivo, indispensabile. Sin da bambina aspettavo che il vento si portasse via la maccaia per sentire la pelle (e anche la mente) più asciutta e pulita, per ritrovare leggerezza e buonumore, energia fisica e spirituale. Mi piace fermarmi ad ascoltare il dialogo tra il vento e il mare e riconoscere la musicalità delle vibrazioni emesse dalle cose toccate dal vento. Queste le pulsioni iniziali istintive che hanno fatto del vento il soggetto della mia ricerca fotografica. Il vento, nonostante la sua immaterialità, esiste, non lo puoi toccare ma c’è e non puoi farne a meno. Se è possibile afferrarlo con la mente, devo essermi detta, posso cercare di fotografarlo. E se la fotografia è la riproduzione o l’interpretazione del visibile, la sfida che dovevo pormi per rappresentare il soffio incorporeo che si frappone tra l’obiettivo e il soggetto inquadrato, era catturarne i giochi, i dispetti, i respiri, le trasparenze, i mutamenti delle cose che solleva, sposta, cambia o semplicemente arruffa e scompiglia. Ho cercato di cogliere l’assoluto nell’assenza.
Non è un segreto che tu sia un’appassionata viaggiatrice, ma al contempo, le tue radici genovesi sono molto forti ed il tuo senso di appartenenza a Genova permea praticamente ogni tua produzione, non a caso il 12 Ottobre del 2018 sei stata insignita “Ambasciatrice di Genova nel Mondo”. Con “Andar per statue”, il tuo ultimo lavoro, ci accompagni in un viaggio curioso, alla scoperta di opere, talvolta nascoste, talvolta ignorate, forse perché troppo presenti, che arricchiscono il suolo ligure, invitando i genovesi a conoscere e apprezzare meglio la propria terra, e i visitatori a scoprire una Liguria aldilà dei luoghi comuni e turistici. Com’è nato questo progetto? Conoscevi già le statue che hai ritratto oppure è stata anche per te una scoperta?
Ammetto che anche per me è stata una scoperta, spesso sorprendente. Mi sono resa conto di aver attraversato strade e piazze decine di volte senza mai essermi soffermata a chiedermi chi potesse essere il personaggio di pietra che incontravo nel mio percorso né perché fosse stato celebrato e piazzato proprio in quel posto. Io e Stefano (Tettamanti, autore dei testi, e anche mio marito), abbiamo attraversato la nostra regione con lo sguardo curioso, cercando di individuare le statue la cui storia meritava di essere raccontata, e abbiamo scoperto che dietro ognuna di loro, anche di quelle più brutte, e francamente non sono poche, c’è un mondo, una visione della storia, un particolare estetico che valeva la pena cogliere e conservare. Se gli uomini da millenni affidano alle statue la conservazione della loro memoria, ci sarà un motivo. E se oggi si abbattano o si sfregiano e imbrattano le statue che non corrispondono più alla nostra visione delle cose in una sorta di damnatio memoriae, è sulla spinta di un revisionismo monumentale idiota prima ancora che criminale. A me andar per statue, consultare questo incredibile archivio storico a cielo aperto, sotto gli occhi di tutti, è piaciuto e mi ha insegnato tante cose che non sapevo. E poi finalmente dei ritratti che non mi hanno messo in imbarazzo, dei modelli che non si muovevano e non sbattevano gli occhi al momento dello scatto…
Concludendo, ti chiedo quali sono i tuoi prossimi impegni e progetti futuri e se puoi anticiparci qualcosa.
Ho in programma la riedizione aggiornata della “Genova di Bacci Pagano” un percorso fotografico a doppio clic: il mio e quello di Gianni Ansaldi. Nella precedente edizione di una decina di anni fa miei erano gli scatti a colori e suoi quelli in bianco/nero, questa volta non so come sarà. Attraverseremo i luoghi della città dove sono ambientati i dodici romanzi con il detective Bacci Pagano di Bruno Morchio, un amico e uno scrittore amatissimo dai genovesi e non solo, e ne trarremo altrettanti itinerari fotografici, classici e insoliti ma tutti affascinanti. Il libro uscirà la prossima primavera/estate per il Canneto editore. C’è poi un progetto ambizioso e internazionale che ha nuovamente per oggetto le statue, una sorta di giro europeo alla scoperta dei monumenti delle personalità che hanno incarnato l’idea d’Europa, da Mozart ai Beatles, da Aristotele a Umberto Eco, da Anne Frank a Virginia Woolf. Ma è presto per parlarne. Fai conto che non ti abbia detto niente…

Grazie Patrizia per la tua disponibilità ed il piacevole pomeriggio.
Se volete scoprire di più su Patrizia Traverso potete visitare il suo sito www.patriziatraverso.it o seguirla sui canali social di Facebook fotonarratrice, Instagram triztraverso.